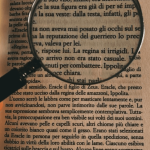di Valentina Vignali
Mi sveglio tutto sudato, al buio, con il cuore a mille, respiro affannosamente e chiudo un attimo gli occhi cercando di calmarmi. È stato solo un incubo. Guardo la sveglia, sono le sei e un quarto del ventitrè novembre, il sole deve ancora sorgere e la città di New York è silenziosa. Ieri era il mio compleanno, cinquantasette anni, nessuno mi ha fatto gli auguri o lasciato un messaggio, ma non mi importa. Scendo dal letto e mi dirigo goffamente verso la cucina, prendo una bottiglia di whisky, non sono un tipo religioso, ma questo liquore è a dir poco miracoloso. Beh sì, sono una persona realista e un alcolizzato da gran parte della mia vita, ho cercato qualche volta di disintossicarmi e mi piace tutto degli alcolisti anonimi, eccetto il divieto dell’alcol. Questo cattivo vizio è genetico, mio padre era sempre ubriaco fradicio.
Gli unici ricordi che ho di lui sono quando ubriaco o totalmente fatto, veniva a casa con la bottiglia in mano appena uscito dal pub. Mangiava sul divano come un maiale e nella maggior parte dei casi era arrabbiato con tutto e tutti, con la vita; così scagliava la sua rabbia su mia madre, la picchiava come un villano e io mi nascondevo in camera mia cercando di non ascoltare le urla strazianti provenienti dalla stanza a fianco. Vivevamo in una topaia che cadeva a pezzi nei sobborghi di Londra, ho abbandonato la scuola a quindici anni per aiutare economicamente la mia famiglia, se così si poteva chiamare. Lavori di ore e ore sottopagati, faticosi e pesanti, ma non mi sono mai tirato indietro, anzi mi hanno permesso di mettere su un po’ di muscoli e difendermi da mio padre quando cercava di maltrattarci. Quando avevo diciotto anni tornando a casa da un turno di dieci ore in cantiere, nel cortile di quel rudere che chiamavo casa, c’erano diverse auto della polizia che stavano trascinando fuori il mio vecchio. L’avevo visto altre volte messo male, ma mai così tanto. Quel giorno mia madre è stata massacrata di botte fino alla morte e mio padre è stato rinchiuso a vita. Ricordo che la pioggia cadeva fitta e le mie gambe tremavano, non volevo sapere niente e non volevo vedere mio padre, perché non mi sarei trattenuto e così sono salito sul primo volo e sono arrivato nella grande New York.
Ricordo che ho iniziato a lavorare in uno squallido locale, dormivo dove capitava, non avevo amici, ma trovavo sempre il tempo per un sorso di rum per affogare i miei malesseri e non ricordare gli incubi che mi tormentavano ogni notte. Dicono che le tragedie rafforzano i giovani e forse è vero, ma posso dire che li segnano a vita e non è affatto piacevole.
Cerco di fermare i pensieri e lasciare la bottiglia di whisky, mi vesto con i miei stracci consumati e puzzolenti vado in bagno e mi osservo, l’unica cosa che vorrei fare è vomitare da quanto mi fa schifo la mia immagine. Penso al grande Stephen Glenn Martin, è proprio vero che da lui ho preso solo il nome, sono un ammasso di spazzatura anzi forse peggio, i capelli spettinati, la barba bianca macchiata e il viso cotto dal sole con visibili rughe, gli occhi arrossati da chissà quale sostanza. Mi faccio ribrezzo, ma in fondo a nessuno importa, quindi me ne frego ed esco dal cadente monolocale della periferia di New York iniziando a salire le scale del palazzo e pensando ai pochi anni felici.
Ah, quei pochi stupendi istanti indimenticabili, a ventitrè anni le cose sembravano andar meglio, avevo un piccolo appartamento con altri due ragazzi sopra alla caffetteria dove lavoravo, non prendevo molto, ma era un luogo piacevole. Il sedici maggio sembrava una mattina normale come tutte quando andai ad un tavolo per le ordinazioni e vidi un angelo, era la ragazza più bella che avessi mai visto. Aveva i capelli rossi che le cadevano sulle spalle, un viso giovane grazioso, ma la cosa che attirò di più la mia attenzione e mi fregò furono gli occhi, due grandi orbite color mare, il mare dopo una tempesta, erano di un blu scuro con qualche sfumatura di grigio, a dir poco stupendi. Non potevo lasciarla scappare, così pian piano iniziai a scoprire sempre più cose su di lei, il suo nome era Rose, frequentava il secondo anno di università e adorava il cappuccino caldo e con il passare del tempo presi coraggio e le chiesi di uscire. Un appuntamento, poi due, tre, quattro e così via, adoravamo passare il tempo insieme, passeggiavamo per Central Park, prendevamo un gelato, ci trovavamo nella caffetteria e così ci mettemmo insieme e fu il giorno più bello della mia vita. Mi sentivo finalmente amato, qualcuno si preoccupava di me, mi aiutava se stavo male, si allarmava se ero in ritardo e cercava in tutti i modi di farmi sorridere e io cercavo di fare lo stesso con quel poco che avevo. Erano due anni che stavamo insieme, l’amavo come il primo giorno se non di più, ma lei iniziò a parlare di convivenza, figli e di formare una famiglia tutta nostra; andava avanti con questa cantilena da diversi mesi, vedevo i suoi occhi illuminarsi ogni volta che incontravamo un bambino per strada e sorrideva ammirando quei piccoli esserini. In quel periodo dormivo poco la notte, non ci riuscivo, ero avvolto dai miei peggiori nemici: i pensieri. Era una fredda notte d’inverno quando presi la fatidica decisione. Di solo tre cose ero sicuro nella mia vita: ero uno scarto della società nato per errore da una famiglia indecente; se fossi mai diventato padre sarei stato uno schifo peggio del mio, spesso avevo attacchi di rabbia e probabilmente il mio ipotetico figlio poteva rischiare non solo un’infanzia tremenda, ma anche un padre assente e l’ultima cosa di cui ero sicuro era che Rose era l’unica cosa bella della mia vita, l’unica persona che amavo davvero. Ero sempre stato arrogante, menefreghista ed egoista, ma lei era l’unica persona che volevo proteggere, proteggere da me stesso, non potevo permettere che perdesse tempo con uno come me, io l’amavo, ma lei voleva una famiglia una vita serena e io quella serenità non potevo dargliela, vivevo da sempre nel caos, non ero destinato, non era abituato alla normalità, mi stava stretta. Così quella notte presi l’unica decisione giusta della mia vita, salvare Rose da me, dandole la possibilità di avere la vita che desiderava anche se questo voleva dire perderla per sempre. L’indomani avevamo appuntamento al parco, voleva parlarmi della casetta che aveva visto, che definiva perfetta per costruire una famiglia, ma quando si sedette sulla nostra panchina, di fianco al grande albero, io non c’ero, al mio posto trovò una lunga lettera che avevo scritto almeno un centinaio di volte, in cui le dicevo quanto l’amavo e il perché della mia decisione. Lei non si diede per vinta, mi cercò, ma io feci di tutto per allontanarla da me, cambiai casa e lavoro e non ci incontrammo più. Poi, qualche anno più tardi, mentre andavo a lavoro la vidi, le sue bellissime ciocche rosse erano raccolte in uno chignon, al suo fianco c’era un uomo, alto, snello e ben vestito mentre in braccio aveva una dolce bambina con le gote rosse e gli occhi color mare come la madre. Rose non si accorse di me, era troppo occupata a richiamare a gran voce un bimbetto che correva spensierato e portava il mio nome. Non nego che quella scena mi commosse, per un attimo invidiai quell’uomo, poi pensai che avevo fatto la cosa giusta e avevo regalato a tutti i passanti questo spettacolo bellissimo: la mia Rose raggiante e sorridente circondata dalla sua amorevole famiglia. Era felice e questo mi scaldò il cuore. Mi incamminai verso il mio lavoro sottopagato con il più grande sorriso che avessi mai avuto, probabilmente i passanti pensarono che fossiun idiota, ma non mi interessava, la mia donna era finalmente felice ed io non potevo desiderare di più.
Mi fermo in mezzo alla rampa per il dolore, un dolore acuto alle gambe per lo sforzo nel salire tutti quei gradini e uno più straziante al cuore nel ricordare la mia amata. Prendo fiato e osservo la bottiglia di whisky, rido di cuore, ora prendo le bottiglie anche senza accorgermene, butto giù un lungo sorso sento il bruciore che scende, ah quante volte ho sentito questa sensazione, forse troppe, già, decisamente troppe.
Quando lasciai Rose sapevo che era la cosa giusta, ma mi provocò un dolore e un vuoto immenso, quindi l’unica soluzione che conoscevo per alleviare le mie pene era buttarmi nell’alcol. Così è iniziata la mia rovina, mi rifugiavo nei bar più depravati bevevo fino allo sfinimento finchè non mi reggevo più in piedi e dovevano trascinarmi fuori dal locale, ero il primo cliente della mattina e l’ultimo della sera. Se non mi trovavo a bere ero in compagnia di qualche prostituta da quattro soldi per cercare di ricevere un po’ di compagnia dal misero sesso o mi stavo facendo di chissà quale scadente droga. Cambiavo lavoro quasi ogni due mesi, dormivo dove capitava, non avevo una casa, frequentavo la periferia e con essa gente poco raccomandabile, spendevo tutto il mio stipendio per pagarmi da bere e fumare, puzzavo ed ero sporco dentro e fuori.
Finii anche in carcere un paio di volte, mi obbligarono a frequentare gli alcolisti anonimi, beh alcolista lo ero, anonimo no di certo, quando c’era da bere chiamavano me, io c’ero sempre per annegare i dolori nel whisky scadente, la mia vita era monotona, ripetitiva. Poi un bel giorno mi giunse la notizia della morte di mio padre, non persi tempo mi fiondai nel bar più vicino e offri da bere a tutti i presenti, festeggiammo fino allo sfinimento, fino all’alba, fu la notte più sfrenata di tutta la mia vita posso giurare di non aver mai riso tanto.
Continuai con questo stile di vita fino ad ora, mentre salgo gli ultimi gradini, apro la porta che conduce alla terrazza, l’aria fresca autunnale mi risale dalle narici osservo il cielo grigio mi ricorda i suoi occhi, aspetto qualche secondo butto giù un lungo sorso poi mi metto a gridare: “Tutto qui? È solo questa la tua grandezza?”. Rido. “Visto? Tutto il dolore che mi hai fatto patire non è servito!” Respiro e sorrido. “Visto? Sono vivo! Steve Jones è ancora qui!”. Urlo al cielo. Non so a chi mi rivolgo, forse a Dio, forse al destino o alla maligna vita, ma l’unica risposta che ottengo è il suono delle rondini in lontananza. Mi dirigo barcollando al cornicione, da quassù si vede tutta la città che si sta lentamente svegliando. Bevo un sorso e lancio la bottiglia che si rompe in mille pezzi per terra e sussurro guardando giù. “Non sei riuscito ad uccidermi non ce l’hai fatta”. Sorrido. “Ah vecchio mio, me ne hai fatte passare tante, ma non deciderai la mia morte, no questo non te lo permetto… lo farò io, non ho bisogno di te, di nessuno, è ora di dire basta”.
Faccio un passo, l’aria mi sposta i capelli e mi gonfia i vestiti logori, sono felice e completo, avevo finalmente trovato la mia felicità, quella che cercavo da tutta la vita e mentre sorrido cadendo da trenta metri l’unico mio pensiero felice è che tutte le luci della città non potranno mai brillare come i suoi occhi.